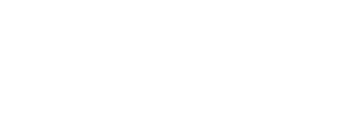Celebrazione dei Trattati di Roma. Un’opportunità per un nuovo slancio nella cooperazione giudiziaria e di polizia nell’UE
Il 25 marzo del 1957 a Roma, nei Saloni del Campidoglio, i rappresentanti di Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo firmarono i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA, o EURATOM).
I ccdd. “Trattati di Roma” – aggiunti a quello fondativo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) già istituita nel 1951 – rappresentano lo storico atto di nascita della Comunità Europea, poi trasformatasi nell’attuale Unione.
Integrare le economie nazionali e mettere in comune ricerca e materie prime alla base della produzione di armi, allo scopo di rendere impensabile e impossibile il sorgere di una nuova guerra tra Paesi europei, furono le basi politiche della nascita dell’Europa Unita. Un progetto che cominciò a materializzarsi in quella circostanza con la creazione di un mercato comune e di istituzioni comunitarie.
L’Europa Unita venne immaginata per la prima volta tra le Due Guerre, quando Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Conte cosmopolita, con radici tra la Europa Centrale e l’Asia – la propose quale antidoto idoneo ad evitare ulteriori immani tragedie, come quelle scatenate dalla Grande Guerra.
A portare avanti tale progetto sono stati alcuni uomini provenienti da zone di confine, funestate da guerre secolari, come il francese Robert Schuman o il trentino Alcide De Gasperi; visionari cosmopoliti come Jean Monnet, o grandi cancellieri come Konrad Adenauer, o anticipatori quali Altiero Spinelli.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale sono stati in molti a propendere per un ripensamento dell’Europa in chiave federalista per costruire un nuovo continente più coeso, capace di fare da cuscinetto al nuovo pericolo che veniva da est, rappresentato in concreto dal Comunismo. È in quest’ottica che sono iniziate le prime trattative soprattutto fra tre paesi: l’Italia, la Francia e la Germania. Dopo un tentativo fallito di rendere l’Europa un soggetto più saldo politicamente, si intraprese, con i Trattati di Roma del 1957, la via dell’Unità Economica. Un’unità che tra mille difficoltà, slanci, allargamenti e polemiche, è giunta nel corso degli anni al raggiungimento di un obiettivo importante: la creazione di una vera e propria unità economica, sancita dal Trattato di Maastricht del 1992 che prevedeva, tra le altre cose, la creazione di una banca centrale e di una moneta unica.
In riferimento alle radici comuni di carattere storico-religioso quando si cominciava a parlare di Europa unita, alla fine del secondo conflitto mondiale, sul Soglio pontificio sedeva Pio XII, favorevole alla formazione del nuovo soggetto politico. Nel corso degli anni l’Europa, tra mille difficoltà, diventa una realtà politica (ma soprattutto economica) importante ed i Papi, da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II, passando per Paolo VI, hanno contribuito al suo rafforzamento.
Il cammino compiuto in venticinque anni dall’Europa, dalla caduta del muro di Berlino all’entrata dei Paesi del blocco orientale nell’UE, si è concretizzata temporalmente con alcune date da ricordare: il 9 novembre del 1989, con la caduta del muro di Berlino e la Cortina di Ferro che separava l’Europa; nel 2004, dopo anni di avvicinamento, con l’ingresso nell’Unione Europea di Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Malta, Cipro, nonché Estonia, Lettonia e Lituania; nel 2007 sono entrate a far parte dell’Unione Romania e Bulgaria; nel 2013 anche la Croazia ha aderito alla Comunità Europea.
La crisi economica e politica di questi ultimi anni rischia però di incrinare l’unità dei 27 paesi europei, un’unità che tra difficoltà e contraddizioni ha comunque garantito un periodo di pace e prosperità al Continente.
Il caso della Brexit ne è un esempio emblematico.
Sessant’anni fa i leader dei sei Stati membri fondatori si sono riuniti a Roma per sottoscrivere la creazione di un mercato comune europeo, ma soprattutto per sottoscrivere un’unione per la pace e per la prosperità che si è poi estesa nella maggior parte del nostro Continente.
L’integrazione commerciale avviata nel 1957 ha coinvolto negli anni sempre più Paesi attratti dai successi dei Paesi che ne avevano aderito inizialmente. La Comunità Economica Europea ha posto alla base della sua politica economico-commerciale la rimozione dei dazi doganali tra gli Stati membri e la libera circolazione delle merci, di servizi, di capitali e di persone. I settori di cooperazione sono aumentati nel corso del tempo portando alla creazione dell’attuale Unione Europea.
Il trattato che ha sancito la nascita della Comunità Economica Europea è passato attraverso molteplici adeguamenti, ora meglio noto come il “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
Con la celebrazione dei Trattati del 1957, il Presidente del Parlamento Antonio Tajani si è recato sabato 25 marzo 2017 a Roma dove ha preso parte a diversi incontri e partecipato alle celebrazioni per il sessantesimo anniversario. In tale occasione Tajani ha firmato, a nome del Parlamento, il testo della dichiarazione comune UE.
Il Parlamento ha avviato negli ultimi mesi una profonda riflessione su come l’Unione Europea dovrebbe evolvere per meglio rispondere alle sfide moderne: migrazione, squilibri economici e Brexit. Gli eurodeputati hanno adottato tre relazioni sul futuro dell’Europa durante la plenaria di Febbraio. Alla seduta di Marzo invece, hanno discusso un documento di strategia della Commissione Europea che definisce cinque possibili scenari per l’UE. Il dibattito è proseguito a Roma nei colloqui tra i vari Capi di Stato.
Il Presidente Tajani ha dichiarato: “L’Europa è la nostra libertà, l’Europa è il nostro futuro e questo è ciò che dobbiamo consegnare ai nostri figli; un futuro di prosperità, di pace e di libertà.”
È evidente la sfida per il diritto penale che viene dalla Unione politica ed economica. A libera circolazione delle positività, deve corrispondere libera circolazione dei provvedimenti giurisdizionali. Solo in detto modo, potrà fronteggiarsi seriamente la sfida della criminalità transnazionale che, sempre più spesso, approfitta callidamente e teleologicamente delle falle nel sistema di cooperazione giudiziaria e di polizia anche tra i Paesi dell’Unione.
Il nuovo slancio conferito dalle celebrazioni di Roma e l’intervenuta attuazione proprio nel nostro Paese delle Direttive sulla cooperazione di indagine ne sono plastico esempio.