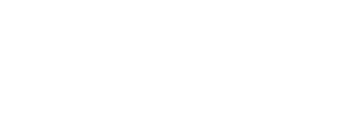ANCORA IN TEMA LIBERTÁ DI ESPRESSIONE
Corte Europea Diritti dell’Uomo, Sez. I, sent. 16 gennaio 2020 Magosso-Brindiani c/ Italia, Ricorso 59347/11.
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla libertà d’espressione di due giornalisti, ritenendo che il reato di diffamazione non si realizzi se il giornalista riporta dichiarazioni di terzi secondo le regole professionali.
L’Italia, a distanza di pochi mesi dalla precedente Sentenza 7 marzo 2019[1], subisce un’altra condanna in ordine ad un ricorso alla Corte europea dei Diritti dell’uomo in tema di reati di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 c.p. comma terzo, ritenendo i Giudici di Strasburgo non necessaria l’ingerenza dello Stato italiano sul diritto di libertà di espressione, tanto più nei casi, come quello si specie, in cui si verifichi, che l’operatore ha trattato la notizia secondo le regole professionali. La recentissima pronuncia della CEDU conferma quindi nuovamente, quanto la Commissione di Venezia[2] già nel 2013 aveva rilevato, ovvero che la legge italiana in materia di reati di diffamazione non risulta ad oggi conforme alle previsioni dell’art. 10 CEDU. Il caso, tuttavia, è intrinsecamente legato alla storia d’Italia durante gli anni del regime di piombo e merita approfondimento
Nel caso di specie i Ricorrenti, rispettivamente all’epoca dei fatti, giornalista e direttore responsabile di un noto settimanale italiano, avevano offerto alla cronaca nel 2004 un articolo dal titolo «Tobagi poteva essere salvato», riportando in esclusiva il racconto di un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri che, sei mesi prima del delitto, aveva ricevuto notizie da un informatore circa la volontà di un gruppo armato di assassinare il giornalista del Corriere della Sera W.T.
A seguito della pubblicazione dell’articolo, infatti, proprio un esponente dell’Arma, e un di Lui parente, querelavano i Ricorrenti, che in data 22 marzo 2006 venivano così rinviati a giudizio avanti il Tribunale di Monza, con l’accusa di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’attribuzione di fatti determinati.
Conclusosi il procedimento di primo grado, con sentenza del 20 settembre 2007 il Tribunale di Monza dichiarava, nonostante le ampie difese, gli imputati colpevoli del reato di diffamazione aggravata, infliggendo una multa di 1.000 € al primo ricorrente e di 300 € al secondo, condannandoli al pagamento di un importante risarcimento alla persone offese costituite, ovvero di 120.000 € al capitano A.R. e 90.000 € alla sorella di U.B., oltre al pagamento in solido delle spese processuali e alla pubblicazione di un estratto della sentenza sul settimanale Gente e sul quotidiano Corriere della Sera.
I ricorrenti, ritenendo la sentenza sproporzionata soprattutto nella parte del risarcimento, proponevano impugnazione, ma la Corte d’appello di Milano con sentenza del 3 novembre 2009 respingeva il ricorso dei giornalisti e dell’ex brigadiere D.C. (ovvero colui che aveva rilasciato l’intervista ai giornalisti), avendo nel frattempo riunito il procedimento a carico di quest’ultimo con quello a carico dei primi, motivando che: «l’articolo è di indiscutibile contenuto diffamatorio, suggerendo nella sostanza ai lettori la conclusione di una dolosa inattività da parte di due ufficiali (…) si ritiene di dover innanzi tutto rilevare come nella specie sia stato violato il principio di verità dei fatti narrati»[3].
Gli imputati presentavano, pertanto, ricorso per Cassazione, ove censuravano le precedenti sentenze, affermando di aver adempiuto all’obbligo di verificare la veridicità delle affermazioni dell’ex brigadiere e pertanto di aver seguito le regole professionali nella loro attività. Tuttavia, con sentenza del 23 novembre 2010 e depositata il 28 marzo 2011, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso, confermando la condanna al pagamento della somma provvisionale di 120.000 €, condannando in solido i giornalisti, con l’ex brigadiere, a rimborsare le spese di lite. In particolare nelle motivazioni della sentenza della Suprema Corte si legge che: «la ricostruzione dei fatti – intrinsecamente screditanti, dal significato immorale sul piano umano, sleale sul piano istituzionale, criminoso sul piano giuridico – ha avuto come prima fonte storica nelle dichiarazioni dell’ex brigadiere, ha avuto come strumento di diffusione nella persona del primo ricorrente, che l’ha condivisa e le ha dato ampio rilievo, ed è stata pubblicata sul settimanale, il cui direttore ha omesso il preventivo controllo richiesto dalla legge».
La questione non poteva poi non approdare anche in sede europea, ove i Giudici di Strasburgo, ricevuto il ricorso, hanno in primis osservato che le parti non hanno mai messo in discussione il fatto, che la condanna dei ricorrenti avesse costituito un’ingerenza nel diritto di questi ultimi alla libertà di espressione, come espressamente sancito dall’articolo 10 della Convenzione[4]. La Corte osserva, infatti, che tale ingerenza sebbene è «prevista dalla legge», nella fattispecie gli articoli 57 e 595 del codice penale e l’articolo 13 della legge sulla stampa, perseguendo uno scopo legittimo, ossia la «protezione dei diritti altrui»[5], pare non proporzionata, tanto che le motivazioni dei giudici interni, nei procedimenti in oggetto, risultano labilmente pertinenti e sufficienti[6].
Da questo punto di vista, la Corte europea ha così ritenuto infondata la condanna attribuita ai due professionisti del settore dell’informazione precisamente sotto il criterio della proporzionalità. Tanto più che i giudici di Strasburgo rilevano che il tono generale dell’articolo non fosse offensivo o ingiurioso[7] e che il suo contenuto non consistesse in attacchi personali diretti specificamente ai due ufficiali in questione. Soprattutto in vista del fatto che i ricorrenti si sono premurati di indicare che la reputazione dei carabinieri non era in discussione e che lo scopo dell’articolo era «ristabilire la verità» ed interrogarsi sul funzionamento del corpo dei Carabinieri durante gli «anni di piombo».
Nella fattispecie, la Corte considera che i tribunali interni non abbiano sistematicamente operato una distinzione tra le affermazioni fatte dal primo ricorrente e quelle di D.C[8], poiché hanno ritenuto che l’articolo avesse un carattere diffamatorio e hanno dichiarato che il primo ricorrente era corresponsabile del delitto di diffamazione, in quanto aveva «aderito alla tesi della dolosa inattività dei carabinieri», dimostrando così apoditticamente la volontà di nuocere a degli ufficiali del Corpo dei Carabinieri. Quanto al secondo ricorrente, questi è stato considerato responsabile di omissione per non aver proceduto a un controllo prima della diffusione di affermazioni potenzialmente diffamatorie.
La Corte osserva, infine, che i ricorrenti hanno peraltro fornito un numero consistente di documenti e di elementi di fatto, che hanno permesso di dimostrare come i controlli effettuati avessero condotto a ritenere le dichiarazioni di D.C. (l’ex brigadiere) come attendibili e pertanto che il loro operato fosse ampiamente conforme alle regole dell’arte giornalistica, come previste nello Stato membro. La Corte rammenta infine che il grado di precisione richiesto per stabilire la fondatezza di un’accusa in materia penale da parte di un Tribunale è difficilmente paragonabile a quello che un giornalista dovrebbe osservare quando si esprime su un argomento di interesse pubblico[9], risultando per quest’ultimo sufficiente una verifica approfondita circa l’attendibilità della notizia e della fonte, senza la dimostrazione della certezza del fatto.
Si approfondirà maggiormente la presente sentenza, che nel dettaglio offre un quadro particolare del clima politico dell’Italia degli anni 80, ma che soprattutto permette di analizzare un tema che rappresenta un chiaro tallone d’Achille del nostro sistema penale, come peraltro rilevato più volte in sede europea, tanto che, come già rilevato dalla precedente sentenza CEDU del 7 marzo 2019, la più recente sentenza del 16 gennaio 2020 ha riconfermato l’Italia responsabile di non aver un adeguato disposto in materia di repressività del reato diffamazione a mezzo stampa, ritenendo lo stesso art. 3 della L. n.47/1948 eccessivo nelle previsioni sanzionatorie, tanto da costituire un’ingiustificata ed indiretta limitazione alla libertà di espressione, come sancita dall’art. 10 CEDU.
[1] Corte Europea Diritti dell’Uomo, Sez. I, Sentenza 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia, Ricorso n. 22350/13.
[2] Opinion n. 715/2013, 9 novembre 2013, in http://www.assembly.coe.int. On 9 November 2013 the Venice Commission, in Opinion no. 715/2013 (“Opinion on the Legislation on Defamation of Italy”) observed that a reform of the legislation on defamation was ongoing (see paragraph 30 above): the amendments proposed envisaged, inter alia, limitation of the use of criminal provisions, abolition of imprisonment as a possible penalty and an upper limit for fines, lacking in Article 595 §§ 3 and 4 of the Criminal Code (repealed by the Bill). The Venice Commission was of the opinion that (high fines posed “a threat with almost as much chilling effect as imprisonment”) but also recalled that this was to be regarded as “a remarkable improvement, in accordance with the Council of Europe calls for lighter sanctions for defamation”.
[3]Estratto dalla Sentenza CEDU, Sez. I, sent. 16 gennaio 2020.
[4] CEDU sent. Kapsis e Danikas c. Grecia, Ricorso n. 52137/12, 19 gennaio 2017; CEDU sent. Belpietro c. Italia, Ricorso n. 43612/10, 24 settembre 2013
[5] CEDU, sent. Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, Ricorso n. 49017/99.
[6] CEDU Sent. Ólafsson c. Islanda, n. 58493/13, 16 marzo 2017.
[7] CEDU, sent. Radobuljac c. Croazia, n. 51000/11, § 66, 28 giugno 2016
[8] CEDU, sent. Ólafsson c. Islanda, n. 58493/13, § 59, 16 marzo 2017
[9] CEDU Sent. Cojocaru c. Romania, n. 32104/06, § 29, 10 febbraio 2015
Scarica il documento in PDF ANCORA IN TEMA LIBERTÁ DI ESPRESSIONE