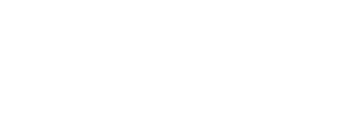L’evoluzione normativa volta a fronteggiare i fenomeni corruttivi
Considerazioni generali.
Usando un’immagine metaforica, potremmo dire che la corruzione si sviluppa nel buio e si dissolve di fronte alla luce; fuor di metafora la lotta alla corruzione esige una sempre maggiore “trasparenza” della pubblica amministrazione, affinché la collettività possa immediatamente comprendere il perché di determinate scelte e soluzioni, aventi non di rado un impatto estremamente significativo sulla vita quotidiana di ognuno di noi [1].
Parimenti, agevolare l’accessibilità agli atti della P.A. significa consentire il controllo sociale e permettere di prevenire e di contrastare i fenomeni di illegalità.
Risulta ispirato a quest’ottica, al pari del provvedimento ad esso immediatamente precedente, e cioè l’art. 5 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il d.lgs. n. 97 del 2016, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che sotto più di un aspetto trae le sue radici ideali dal c.d. Freedom of Information Act (FOIA) nordamericano, modellato secondo lo spirito dell’ opened approach, alla luce del principio del maximum disclosure.
Può osservarsi come detta impostazione rappresenti per il nostro Paese il segnale di una netta evoluzione, se non di un vero e proprio mutamento di rotta, rispetto ad un passato relativamente recente, ispirato al criterio, sancito dagli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 1990, in base al quale il diritto ad ottenere l’informazione sul contenuto degli atti doveva essere necessariamente correlato ad un ‹‹interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso››.
Oggi invece, come già accennato, è possibile, grazie ad un accesso facilitato agli atti della P.A., un controllo “diffuso” sulle modalità di funzionamento della stessa e sull’utilizzo delle risorse pubbliche., ormai indipendente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, e volto a fare della pubblica amministrazione una vera “casa di vetro” [2], ove ognuno può essere in grado di conoscerne i meccanismi, le attività e le decisioni, essendo la trasparenza una sorta di “patrimonio” della collettività [3].
Non a caso l’art. 2 del d. lgs. n. 97 del 2016 collega il principio di trasparenza alla possibilità di un accesso ampio ai dati e ai documenti della pubblica amministrazione.
L’art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016, nel riscrivere l’art. 5 del d. lgs. n. 33 del 2013, delineando quello che può essere definito il “nuovo diritto di accesso”, ha sancito che l’esercizio di questo diritto non deve essere sottoposto ad alcuna limitazione in relazione alla legittimazione soggettiva.
Peraltro, anche se il contrasto alla corruzione esige interventi strutturali riformatori, come quello sovramenzionato, e non può essere condotto unicamente per mezzo dello strumento penale sanzionatorio, da esso non può comunque prescindere.
Per comprendere la valenza delle più recenti modifiche nel settore penale concercenti la tematica in oggetto occorre richiamare brevemente il quadro originario delineato dal codice del 1930; non sarebbe altrimenti adeguatamente valutabile il senso della sostituzione della precedente figura della corruzione per un atto d’ufficio con l’attuale fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, nonchè la portata dell’introduzione della corruzione tra privati o del nuovo delitto di traffico di influenze illecite e la scomposizione della vecchia figura di concussione in due distinte incriminazioni, l’una delle quali ha conservato la denominazione di concussione (ma è stata riservata alle sole ipotesi di autentica “costrizione“ del privato alla dazione o promessa di denaro o di altra utilità), mentre l’altra fa ora riferimento all‘“induzione“ mediante abuso dei poteri o della funzione [4].
Su questa tematica ha inciso in profondità la riforma operata dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, che non è intervenuta comunque solo sulla normativa del codice penale, in quanto, con riferimento alla corruzione tra privati, ha inciso anche sulla l. n. 231 del 2001, nonchè sul codice civile, mediante la riformulazione dell’art. 2635 c.c., permettendo in tal modo, tra l’altro, l’adeguamento della disciplina interna (seppur ancora solo parziale, come vedremo nel prosieguo della trattazione) agli obblighi internazionali in tema di lotta alla corruzione, discendenti, tra l’altro, dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 (c.d. Convenzione di Merida), ratificata dall’Italia in forza della l. 3 agosto 2009, n. 116.
Come noto, il codice del 1930, nella sua originaria dizione, prevedeva due figure principali di corruzione. La prima era la corruzione per un atto di ufficio, detta anche corruzione impropria, regolamentata dall’art. 318 c.p., e che comprendeva la c.d. corruzione impropria antecedente passiva (consistente nella ricezione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa o della dazione di denaro o di altra utilità quale indebita retribuzione per compiere un atto del proprio ufficio) e la c.d. corruzione impropria susseguente passiva (che ricollegava tale promessa o dazione all’avvenuto compimento di un atto d’ufficio).
La corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, o corruzione “propria“, disciplinata dall’art. 319 c.p., si scindeva parimenti nelle due sottocategorie della c.d. corruzione propria passiva antecedente e della corruzione propria passiva susseguente, e consisteva nella condotta del pubblico ufficiale che «per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa».
L’art 320 c.p. estendeva poi tali incriminazioni anche alle condotte poste in essere da un incaricato di un pubblico servizio, mentre l’art. 321 incriminava la corruzione “attiva“, sanzionando il privato che avesse dato o promesso denaro od altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio con riferimento alle ipotesi di corruzione propria antecedente e susseguente e corruzione impropria antecedente; veniva invece esclusa la punibilità del privato con riferimento alle ipotesi di corruzione impropria susseguente, consistenti, come già abbiamo visto, nella promessa o dazione di denaro o di altra utilità per l’avvenuto compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto del proprio ufficio.
La riforma operata dalla l. n. 190 del 2012 e le successive modifiche.
A seguito della riforma, definita “di sistema“, operata dalla l. n. 190 del 2012 [5], il delitto di corruzione impropria è stato sostituito con quello di “corruzione per l’esercizio delle funzioni“, secondo la nuova dizione dell’art. 318 c.p. Sono invece rimaste sostanzialmente invariate le ipotesi di cui all’art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari) e 322 bis c.p. (corruzione internazionale).
Il mutamento che ha interessato l’art. 318 c.p. non è certo limitato alla sola differente denominazione della fattispecie incriminatrice. Rispetto alla precedente configurazione infatti ora non è più necessaria l’individuazione di uno specifico atto o di una specifica condotta costituente oggetto dell’illecita dazione o promessa, venendo attualmente sanzionata ogni ipotesi di “monetizzazione“ del potere pubblico, anche se sganciata da un nesso sinallagmatico con il compimento di un ben preciso atto.
Nella versione riformulata l’art. 318 c.p. punisce la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità al pubblico funzionario «per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri». Inoltre, mentre in passato il privato non era incriminato con riferimento alle ipotesi di corruzione impropria susseguente, tale impostazione è ora venuta meno; viene conseguentemente sanzionato anche il privato che dia o prometta denaro od altra utilità al pubblico funzionario per ringraziarlo dell’avvenuto compimento di un atto dovuto.
Ovviamente ciò non significa che debba giungersi all’incriminazione dei regali d’uso, fatti dai privati in occasione di festività o ricorrenze; a presidio di una correrttga applicazione della norma rimane infatti la doverosa considerazione del criterio di offensività.
Il problema, semmai, è rappresentato dai casi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio risulta posto “a libro paga“ di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, e cioè dalle ipotesi connotate dallo stabile asservimento ad interessi personali di terzi da parte del pubblico ufficiale, ritenendosi configurabile il più grave delitto di cui all’art. 319.
È stato infatti osservato che sarebbe irragionevole punire meno gravemente il pubblico ufficiale che “venda l’intera funzione“ rispetto a colui che “venda un singolo atto“ [6], essendo in tal caso in presenza di condotte di corruzione c.d, “sistemica“, in cui la promessa o la dazione dell’utilità non è correlata ad un singolo atto d’ufficio determinato o determinabile, bensì alla generalità degli atti della funzione; in simili ipotesi il soggetto rinuncia a priori ad esercitare i propri poteri discrezionali e ad effettuare un‘imparziale comparazione degli interessi in gioco; il reato di corruzione impropria è configurabile, in presenza di una discrezionalità amministrativa, solo qualora l’atto risulti sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni.
Venendo ora alla concussione, è stata profondamente innovata la precedente impostazione dell’art. 317 c.p.p., volto a sanzionare, nell’originario dettagto codicistico, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, avesse costretto o indotto taluno a un’indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità.
Ora l’art. 317 fa riferimento unicamente alla figura della concussione per costrizione, mentre quella che era la concussione per induzione ha dato vita all’autonoma figura, meno grave, dell’induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all’art. 319 quater c.p.
Tale impostazione, a dire il vero, non costituisce una novità assoluta nel panorama legislativo italiano, in quanto essa riprende lo schema del codice Zanardelli del 1889, che, al pari di taluni codici preunitari, tra cui il codice penale toscano del 1853, distingueva la concussione per costrizione da quella per induzione [7].
Peraltro, la l. 190 del 2012 sanziona, sia pur con una pena notevolmente inferiore rispetto a quella prevista a carico del pubblico funzionario, anche il privato che sia stato indotto all’illecita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, laddove il codice Zanardelli escludeva la punibilità per il privato, sia nella concussione per costrizione che per induzione, ritenendo comunque quest’ultimo vittima e non soggetto attivo del reato.
La distinzione tra concussione ed induzione indebita si rivela talvolta difficoltoso [8], ed appare utile seguire al riguardo le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite con la pronuncia Maldera [9].
Le Sezioni Unite hanno sottolineato come il delitto di concussione, di cui all’art. 317 c.p., sia caratterizzato da un abuso costrittivo del pubblico ufficiale (ed ora, nuovamente, anche dell’incaricato di un pubblico servizio, per effetto della sostituzione operata dall’art. 3, comma 1, della l. 27 maggio 2015, n. 69), che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio, si trova di fronte alla scelta se subire il danno ingiusto prospettato o evitarlo mediante la dazione o la promessa di un’utilità indebita.
In tal caso, dunque, quest’ultimo soggetto certat de damno vitando; siamo infatti in presenza di una vittima in stato di totale soggezione.
Il delitto di induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p. concerne invece una condotta di “pressione“ morale, di persuasione, di suggestione, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che prospettando al privato un danno giusto – giacchè conforme alla legge o alla particolare disciplina del settore – quale conseguenza della sua mancata adesione alla richiesta di erogazione di un’indebita utilità, lascia al destinatario della stessa un margine significativo di libertà di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Infatti, in tal caso l’acquiescenza alla richiesta appare motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, ed il soggetto sottoposto ad induzione indebita certat de lucro captando.
Proprio per questo egli viene sottoposto a sanzione, seppure in misura inferiore rispetto al soggetto “inducente“, in quanto non è considerato vittima dell’induzione «ma correo al pari del pubblico funzionario, perchè appunto destinatario di una mera induzione da parte di quest’ultimo e non già di costrizione» [10].
Nell’induzione indebita la volontà del privato non viene “piegata“ dall’altrui sopraffazione, ma “condizionata“ da una pressione esterna [11].
Peraltro, la distinzione tra concussione e induzione indebita impone comunque un’attenta disamina della specificità di ogni singola vicenda.
In particolare, i rispettivi criteri distintivi vengono parzialmente messi in crisi ed esigono una rimeditazione in presenza delle «situazioni cc.dd. miste, di minaccia-offerta o minaccia-promessa»[12]. Infatti, nel caso della minaccia-offerta, occorre esaminare se il privato sia stato indotto a versare l’indebito perchè intendeva conseguire il vantaggio non dovuto prospettato dal pubblico funzionario o in quanto era sotto l’effetto dell’intimidazione.
Non di rado le due motivazioni possono concorrere, ed in tal caso si deve valutare quale di esse appaia prevalente.
Risulta parimenti disagevole la distinzione tra corruzione e induzione indebita [13]. In via di approssimazione, potrebbe affermarsi che mentre nella prima ipotesi si è in presenza di una sorta di “negoziazione“, su un piano di parità tra le parti, nel caso dell’induzione si ha invece una soggezione psicologica del privato, che, sia pur non “costretto“ mediante violenza o minaccia, è comunque “indotto“, secondo la terminologia legislativa, a compiere una determinata dazione o promessa.
Si è sottolineato al riguardo la connotazione ibrida della posizione del soggetto indotto, “in parte vittima ed in parte complice“, evidenziandosi giustamente che l’induzione indebita «rappresenta l’ipotesi intermedia tra la concussione, in cui l’extraneus resta vittima dell’altrui prevaricazione, e la corruzione, connotata da una relazione pienamente paritaria tra le parti (par condicio contractualis)», e rilevandosi come il nuovo reato di induzione sia stato collocato in posizione mediana anche dal punto di vista della pena edittale, in quanto l’abuso induttivo del pubblico agente è ora punito nel massimo più severamente della corruzione propria e più tenuamente della concussione [14].
Accanto a tali incriminazioni, il legislatore, onde adeguare la normativa interna agli obblighi internazionali in materia di corruzione, ha poi introdotto, all’art. 346 bis c.p., la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite, sanzionando la condotta di chi, al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e di corruzione in atti giudiziari «sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
Siamo dunque in presenza di condotte prodromiche rispetto a successivi eventuali accordi corruttivi; pertanto la norma non si applica qualora il pubblico ufficiale accetti la promessa o la dazione, giacchè in tal caso si avrà un concorso del privato, dell’intermediario e del pubblico ufficiale nel delitto, consumato, di corruzione.
D’altro canto le relazioni con il pubblico ufficiale da parte dell’intermediario devono essere reali, e dunque davvero esistenti; in caso diverso si verterebbe nel millantato credito, di cui all’art. 346 c.p.p., volto a sanzionare «quella che nella sostanza è una truffa ( a consumazione anticipata) a danno del privato, indotto a dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto che in realtà intende tenere per sè il denaro o l’utilità in questione, senza volere nè potere creare le condizioni per il perfezionamento di un accordo corruttivo tra il privato e qualsiasi pubblico funzionario», tanto che «l’unica proiezione offensiva di carattere pubblicistico, che sola potrebbe spiegare – tra l’altro – il ben più elevato carico sanzionatorio rispetto al delitto di truffa, è identificabile nel mero prestigio della pubblica amministrazione, sotto il profilo dell’immagine di correttezza e non venalità degli esercenti pubbliche funzioni» [15].
La l. n. 190 del 2012, è poi stata modificata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, contenente «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio» [16], che ha reintrodotto, tra l’altro, la figura dell’incaricato di un pubblico servizio tra i soggetti attivi del delitto di concussione, espunto dalla riforma operata dalla l. n. 190 (volta invece a ritenere che i ridotti poteri degli incaricati di pubblici servizi non potessero ingenerare il metus publicae potestatis correlato al delitto di cui all’art. 317 c.p.), ed ha delineato una serie di misure lato sensu premiali, volte ad incentivare la collaborazione post factum da parte sia dei soggetti corrotti che dei corruttori.
Non si è giunti a configurare, sviluppando una logica già delineatasi ai tempi di “Tangentopoli“, secondo schemi largamenti utilizzati negli U.S.A., tale collaborazione come forma di esclusione della punibilità, ma si è delineata una nuova ipotesi di attenuante speciale, di cui all’art. 323-bis, comma due, c.p., consistente in un “ravvediemnto operoso“, rappresentato dalla condotta di «chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite».
Sempre sotto tale aspetto, l’art. 165, comma quarto, c.p., ha previsto che per i reati delineati dagli artt. 317, 318 e 319 c.p. la sospensione condizionale della pena sia «subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio».
Infine, dal punto di vista processuale, l’introdotto art. 444, comma 1-ter c.p.p. ha stabilito che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 317,318 e 319 c.p. l’ammissibilità del patteggiamento sia subordiata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
Il reato di corruzione fra privati.
Trattasi di un reato a concorso necessario, in quanto prevede necessariamente la compartecipazione di una pluralità di soggetti.
In base all’art. 2635, comma 1, c.c. vengono incriminati gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.
Il secondo comma sanziona, sia pur con una pena più ridotta rispetto a quella prevista dal primo comma, i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza, che abbiano posto in essere le attività precedentemente descritte.
Siamo, in entrambe le ipotesi, in presenza di un reato proprio; pertanto, in caso di ignoranza od errore da parte del corruttore circa la titolarità della qualifica soggettiva da parte dell’intraneo, non potendo operare il disposto dell’art. 117 c.p. rimane preeclusa l’estensione della punibilità ai sensi dell’art. 110 c.p.
Il terzo comma della norma delinea invece il fenomeno speculare di corruzione attiva, consistente nella condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità ai predetti soggetti.
Va ricordato che la l. n. 190 del 2012, introducendo l’art. 25 ter nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha inserito la corruzione tra privati, sia pur limitatamente alle ipotesi di corruzione attiva, quali reati preesupposto alla responsabilità amministrativa a carico dell’ente.
Occorre ribadire che viene sanzionato unicamente l’ente al quale appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo detto ente può essere avvantaggiato dalla condotta corruttiva.
Nella dizione originaria, introdotta dalla l. n. 190 del 2012, il legislatore richiedeva l’avvenuto nocumento alla società, derivante da tali condotte, che rappresentava l’evento del reato.
Tale impostazione è stata opportunamente eliminata dal d. lgs. n. 38 del 2017, così come è stata modificata la dizione originaria, volta a fare riferimento alle sole imprese costituite in forma societaria; la previsione è infatti stata estesa anche ai consorzi ed agli altri enti privati.
È al contrario rimasta invariata nella riformulazione della norma la previsione che ne costituisce il principale elemento di debolezza e di criticità, ostacolandone la concreta applicazione, e cioè quella volta a subordinare la procedibilità alla querela della persona offesa, fatta salva l’ipotesi in cui «dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».
Si è giustamente osservato come appaia difficile ipotizzare che la maggioranza dei soci dopo aver eletto ill management decida successivamente di querelarne un membro, aggiungendosi che non risulta parimenti soddisfacente l’impostazione in base alla quale legittimata alla proposizione della querela è unicamente la società cui fa capo il soggetto corrotto, e non anche la società cui fa invece capo il corruttore.
Appare inadeguata anche la previsione concernente la procedibilità di ufficio, correlata alla sussistenza di una distorsione della concorrenza. La verifica circa la sussistenza di un tale elemento imporrebbe infatti lunghi e complessi accertamenti, laddove, trattandosi di un elemento condizionante la procedibilità, esso invece dovrebbe essere di immediata constatazione.
[1] F. Caringella, R. Garofoli, M.T. Sempreviva, L’accesso ai documenti amministrativi, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1 e 4.
[2] Cfr. al riguardo E. Carloni, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, in Dir. pubbl. 2009, n. 3, p. 779 ss.
[3] Cfr. C. Marzuoli, La trasparenza come diritto civico alla pubblicità, in G. Arena, G. Corso, G. Gardini, C. Marzuoli, F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Giuffrè, Milano, 2008, p. 45 ss.
[4] V. al riguardo F. Viganò, La riforma dei delitti di corruzione, in Libro dell’anno del Diritto 2013, Enc. Treccani, p. 1 ss.
[5] V. in tal senso V. Mongillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015, in Dir. pen. cont., 15 dicembre 2015.
[6] M. Minervini, Il controverso rapporto tra i delitti di corruzione e la discrezionalità amministrativa, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2017, n. 12, p. 97.
[7] V. sul punto V. Mongillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione, cit.
[8] M.A. Bartolucci, L’”abuso di qualità” del pubblico ufficiale nel prisma tra concussione e induzione indebita, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1231 ss.; G. Fiandaca, Concussione e induzione indebita tra fatto e prova, in Foro it., 2014, II, c. 517 ss.; A. Manna, La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell’ambito di un quadro d’assieme, in Arch. pen., 2013, p. 1 ss.; V. Mongillo, L’incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuo penale della pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2013, n. 3, p. 166 ss.; M. Pelissero, Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, in C.F. Grosso – M. Pelissero (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, Milano, 2015, p., 173 ss.
[9] Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera ed altri, in Dir. pen. proc., 2014, p. 546 ss., con commenti di S. Seminara, Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite, e di P. Pisa, Una sentenza equilibrata per un problema complesso. Per ulteriori analisi della pronuncia v. R. Bartoli, Le Sezioni Unite tracciano i confini tra concussione, induzione e corruzione, in Giur. it., 2014, c. 1200 ss.; M. Donini, Il cor(reo) indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 ottobre 2013 – 14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in Cass. pen., 2014, p. 1582 ss. ; nonché L. Gatta, La concussione riformata, tra diritto penale e processo. Note a margine di un’importante sentenza delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1566.
[10] R. Garofoli, La nuova disciplina dei reati contro la P.A., in Dir. pen. cont., gennaio 2013, p. 7.
[11] Cass., sez. VI, primo aprile 2014, n. 28978, in Ced Cass., n. 259823.
[12] Cfr. M. A. Bartolucci, L’ “abuso di qualità”, cit., p. 12333 e nota 16, ove viene fatto l’esempio «in cui l’intraneus minaccia un danno ingiusto (ad es., l’esclusione illegittima e arbitraria da una gara d’appalto) ma contestualmente promette un vantaggio indebito (la sicura vincita della gara in caso di dazione o promessa dell’indebito».
[13] Cfr. M. Gambardella, La linea di demarcazione tra corruzione e induzione indebita:i requisiti impliciti del “danno ingiusto” e “vantaggio indebito”, i casi ambigui, le vicende intertemporali, in Cass. pen., 2014, p. 2018 ss.
[14] V. Mongillo, Le riforme, cit., p. 7 e 8.
[15] F. Viganò, La riforma dei delitti di corruzione, cit., p. 16.
[16] V. sul punto V. Mongillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015, cit.
Scarica il Documento in PDF L’evoluzione normativa volta a fronteggiare i fenomeni corruttivi